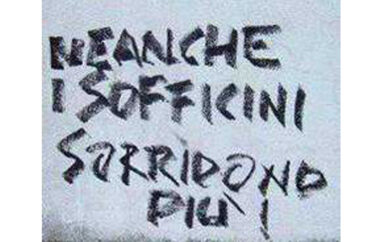“libero, dritto e sano è il tuo arbitrio”
Il tema della “libertà” ci mostra una vasta gamma di vedute, di teorie che ci riesce difficile poter esaurire in due paginette o in un breve intervento pubblico, peraltro rivolto agli studenti, e, dunque, ad un uditorio particolare, ossia giovane e, di conseguenza, ancora sostanzialmente alla ricerca delle origini delle civiltà e dei contenuti che si sono radicati nel corso di millenni non solo nel nostro Occidente europeo, ma anche in regioni euroasiatiche apparentemente lontane da noi. Abbiamo conosciuto le argomentazioni esposte dai Meli relative al senso e al valore della libertà, profondamente difformi rispetto alle considerazioni enunciate dagli ambasciatori ateniesi, per i quali la libertà equivaleva all’espansione del loro impero coloniale a danno di quanti nell’ambito del bacino mediterraneo se ne dissociavano.
Facendo ora un volo pindarico e raggiungendo Dante in esilio, lontano da Firenze per ragioni politiche fin dai primissimi anni del XIV secolo e all’inizio della stagione della composizione della Divina Commedia, incontriamo un personaggio che per la libertà si è suicidato. Costui è Catone. Lo incontriamo a guardia del Purgatorio mentre blocca Dante e Virgilio nel loro cammino che li porterà nel Paradiso. Catone nella Catilinaria sallustiana perora la condanna a morte dei congiurati – democratici -, ossia appartenenti al partito dei “populares”, i cui leader erano, all’epoca, Catilina, ma soprattutto Cesare. La condanna ci fu (ma la morte di questi due personaggi accadrà in momenti diversi e per differenti modalità!) e questo episodio, doloroso ma inevitabile, sancirà una spaccatura definitiva fra l’ala rivoluzionaria cesariana e quella conservatrice dei cosiddetti “nobiles”, aristocratici di antica tradizione, cui si affiancavano anche influenti commercianti (la cosiddetta nuova borghesia). Successivamente, quando Cesare esce vincitore dalla guerra civile, appropriandosi del potere assoluto, Catone preferirà il suicidio alla sottomissione e al perdono del nuovo arbitro della politica a Roma.
E qui, a questo punto cioè, emergono nella Divina Commedia due elementi concettuali che sanciscono una clamorosa rottura dantesca nei confronti della dottrina cristiano/romana di quell’età. Infatti, Catone, suicida e, quindi, per la dottrina cristiana del tempo di Dante, peccatore meritevole delle pene dell’ Inferno, è posto, al contrario, a guardia del Purgatorio. Nel Limbo, poi, disposto nel primo cerchio infernale (canto IV), in cui non si soffrono le pene della dannazione perenne, ma dove si attende il giudizio finale che vedrà le anime, lì momentaneamente collocate, conseguire la beatitudine del Paradiso e quindi la loro completa acquisizione della felicità eterna, nel Limbo, dicevamo, ci sono, tra gli altri, personaggi famosi nel campo della cultura e della politica, naturalmente non cristiani, come i poeti Omero, Orazio, Ovidio, Lucano; la stessa moglie di Catone ossia Marzia; e, poi, un’altra donna famosa nell’antichità come Lucrezia; filosofi, come Socrate, Platone, Aristotele, Averroè e Avicenna; e anche un re, Saladino, il sultano maomettano che ha combattuto contro i crociati lealmente al punto da guadagnarsi stima e ammirazione anche nel campo avversario, quello occidentale/cristiano. E anche Orfeo, il mitico cantore dell’infelice Euridice. E tutto questo ha il senso della libertà di giudizio – quella del cristiano che, pur rimanendo fedele alla dottrina della Chiesa, reclama altresì la libertà di analisi relativa alla storia, alla realtà fenomenica con la quale, lui, Dante, come uomo e cittadino di Firenze, intende fare i conti – della libertà di giudizio, dicevamo, per la quale Dante sacrificò senza compromissioni la sua vita.
Altro elemento rilevante nell’ affermazione della propria libertà di pensiero è la narrazione che riguarda la vita e l’esperienza (mitiche, ovviamente!) di Ulisse, che va incontro alla morte, non volendo rinunciare alla libertà di ricerca del senso autentico della vita, finendo i suoi giorni annegato nell’Oceano Atlantico. Di qui, la Divina Commedia è la narrazione dell’affermazione della libertà, intesa come processo di liberazione da tutte le passioni “devianti”, da quelle forze che contaminano e che, per essere sconfitte, debbono subire e conoscere un processo di affinamento. Prima di separarsi da Dante, la sua guida, ossia Virgilio, così, infatti, lo saluta: “Non aspettar mio dir più né mio cenno,/ libero, dritto e sano è tuo arbitrio,/ e fallo fora non fare a suo senno;/ per ch’io te sovra te corono e mitrio” (vv. 139/142).
A questo punto, richiamandoci in un certo senso alle narrazioni fantapolitiche e catastrofiche nelle quali si passa da un tempo storico ad un altro di gran lunga posteriore, da un’epoca ad una diversa, da un mondo ad un altro contrapposto e sotto certi aspetti sconosciuto, anche noi ci accingiamo a lasciare alle spalle questi universi sociali e politici per approdare al tempo della Resistenza italiana contro il nazifascismo e nel quale per la libertà morirono migliaia e migliaia di cittadine/cittadini, che aspiravano a costruire, come in effetti fu, un mondo diverso, fondato sostanzialmente sulla giustizia, sull’abbattimento delle diseguaglianze sociali, sulla libertà. Nelle parole di una donna partigiana di 103 anni, Iole Mancini, pronunciate nella manifestazione antifascista romana il 25 aprile scorso, riscontriamo il valore profondo della parola “Libertà”: “Sono felice di essere qui con voi, vuol dire che i nostri morti, che hanno sacrificato la loro vita, non sono morti invano. Continuate a lottare, perché non è finito, siamo nel pieno di un ritorno di nostalgici che parlano perché non conoscono le condizioni in cui io vivevo a quei tempi”.
E che dire della distruzione quasi totale dell’Afganistan e dell’Iraq ad opera della Nato e delle nazioni che la sostengono (in primis, gli USA con i paesi europei – compresa l’Italia – a ruota), nazioni nelle quali a pagare le conseguenze nefaste di decennali conflitti ingiusti sono state, e sono tuttora, soprattutto le donne, sempre più emarginate e allontanate dalle sfere pubbliche, dalle amministrazioni, dal lavoro, dalle università? Personaggi femminili come Homa Darabi (1940-1994) – psichiatra iraniana, morta dopo essersi cosparsa sul corpo, nella piazza grande della città di Teheran, una intera tanica di benzina -; oppure, come la ragazza poco più che ventenne, Masha Amini (2000-2022) – ammazzata di percosse dalla polizia morale iraniana – gridano forte la parola “Libertà” in un paese dove le restrizioni socio/politiche e le assurde regole delle leggi desunte da letture distorte del Corano alimentano in noi la tensione civile e la responsabilità dell’ impegno coerente e costante contro ogni limitazione delle libertà collettive ed individuali anche.☺