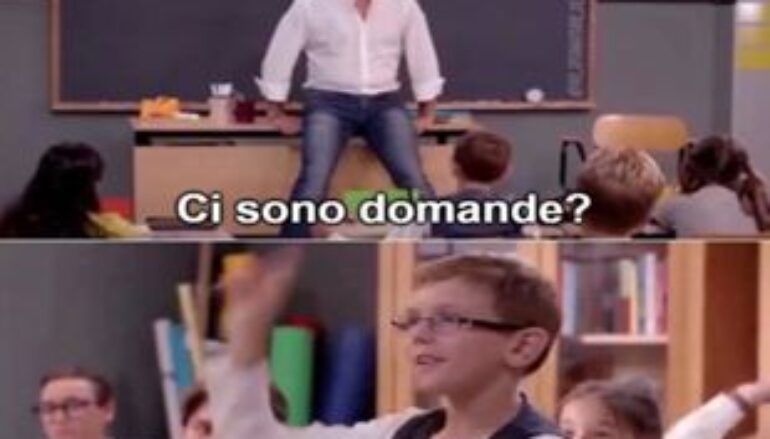
Omaggio a roberto roversi
“Scomparvero nelle piramidi di fuoco.
Quel tempo sporcò di melma le mani
dei sopravvissuti, dai gelidi cancelli
precipitarono ancora ancora
le mandrie nei macelli –
belare straziava la lama dei coltelli
in mano ai giovani carnefici.
Non è questo che voglio: ricordare.
No ritornare a quei lontani
anni, a quei tempi lontani.
I cani erano più felici degli uomini.
I miei versi sono fogli gettati
sopra la terra dei morti.
È oggi che dobbiamo contrastare”.
Questo passo celebre è tratto dall’ opera di Roberto Roversi Dopo Campoformio. Si possono cogliere i momenti centrali della poetica dell’intellettuale bolognese. La poesia come mezzo di contrasto nei confronti della realtà alienata, ma anche di lettura della realtà stratificata di quegli anni, dei tempi cui risalgono le poesie di Dopo Campoformio. La necessità, ma al tempo stesso la libertà di ricordare. Il contrasto tra memoria e azione, tra ricordare e contrastare, tra ieri e oggi. Il dolore che non passa né può passare della memoria dei lager:
“mai fu così prossima la fine.
Non ha più senso toccare le pietre,
l’attesa, il turbine, la tempesta
spezzano non foglie morte ma le cime
degli alberi, la terra;
è troppo tardi”.
La poesia come resistenza, come dovere inappuntabile di resistere ad una realtà che, ancora una volta, delude ed è pronta a deludere qualora si abbassi la guardia. Ma la poesia sta vivendo per Roversi una nuova ed estrema situazione di difficoltà, silenziata o resa inoffensiva dall’industria culturale di massa, in tempi veramente cupi, duri, schematici che non ci hanno emancipato da quegli altri tempi in cui “i cani erano più felici degli uomini”. E ancora la volontà di non gettare la memoria dei morti, le risonanze della guerra terribile che si era combattuta sul suolo d’Italia, nel Vecchio continente. Nel mondo. Furono quelli dei Cinquanta gli anni in cui il poeta raggiunse la sua piena maturità, un suo stile inconfondibile e personale dentro una concezione alta, in senso etico, e precisa della poesia elaborata a partire, come si diceva dianzi, dalla metà degli anni Cinquanta nell’ambito di un discorso “strutturale” e strategico emerso anche all’interno della rivista Officina. Essa condusse “una battaglia su due fronti: da un lato sottopone a revisione la tradizione ermetico-novecentesca e la connessa concezione dell’uomo e dell’artista”, dall’altro sottolineò i limiti di “un facile impegno, incanalato in rigidi schematismi e incapace di costituire un’alternativa accettabile” (M. Marchi). Da qui il rifiuto del neorealismo e delle posizioni ideologiche che lo avevano sostenuto.
Officina godeva di una convergenza, tra gli altri, di tre poeti di antica e liceale frequentazione: Leonetti, Pasolini e Roversi, i quali furono anche compagni di classe, appunto, al Liceo Classico “Galvani” di Bologna. Certamente poi la vita e le sorti personali dei tre autori li portarono in luoghi diversi, ma tra loro vi fu sempre una certa vicinanza e una sostanziale affinità elettiva. Si può sicuramente sostenere che Dopo Campoformio fu la risposta di Roversi, quasi il completamento, a Le Ceneri di Gramsci di Pasolini. Entrambe le opere venivano a confrontarsi con il clima piuttosto chiuso e conformista degli anni Cinquanta, sia in Italia sia nel mondo, dominati dalle rigide contrapposizioni imposte dalla Guerra Fredda, dalla tragedia di Ungheria, le violenze neofasciste in Italia, il Maccartismo negli USA, la sporca guerra di Algeria, e, a Bologna, portando il discorso sul locale, il confronto tra Dozza e Dossetti per il ruolo di sindaco, per citare alcuni eventi centrali di quegli anni dei quali Roversi ebbe a scrivere:
“Mai anni peggiori
di questi che noi viviamo,
né stagione più vile
coprì di rossore la fronte asciutta italiana;
cadavere fulminato
giace essa riversa sull’erba di una trazzera.
Così la sera del nostro vivere umano
quando la morte sprofonda nel fuoco della gola
e resta poca gente, sola,
a vegliare con gli occhi asciutti e a ricordare.

