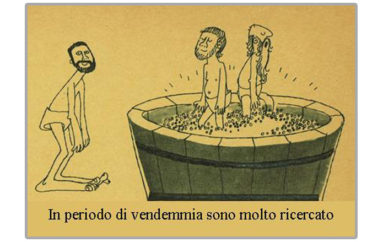Crisi demografica
La crisi demografica che, da tempo, attanaglia l’Italia fa discutere. Si cercano strumenti per porvi rimedio. Si riflette poco sull’invecchiamento, a partire dal 1984, delle generazioni del boom economico e sui cambiamenti demografico-culturali incidenti quantitativamente sui potenziali genitori e i potenziali lavoratori.
Il tasso di fecondità è stato per lungo tempo, mediamente, attorno a cinque o più figli per donna. Esso garantiva, allo stesso tempo, continuità alla popolazione e compensava gli elevati rischi di morte. Non raggiungeva in Italia, a metà dell’Ottocento, il primo anno di vita oltre un nato su cinque e meno della metà dei figli raggiungeva l’età dei genitori. È in atto una transizione demografica, documentata dal passaggio da alti livelli di mortalità e di natalità ai bassi livelli odierni. Il tasso di fecondità per un equilibrato ricambio generazionale passa da cinque (e oltre) a due figli e si abbassano i rischi di mortalità dalla nascita fino all’età adulta e, mediamente, bastano due figli per sostituire due genitori.
Il tasso di fecondità di un Paese stabilizzatosi attorno a due figli modifica la tradizionale struttura piramidale dell’età (molti giovani e pochi anziani). Base e parte centrale diventano simili a un rettangolo e la punta alta (età avanzate) si alza e si allarga, stante la longevità. Rimane solida la base. Tale struttura della piramide può ottenersi anche con un tasso di fecondità poco al di sotto di due figli per donna, se la riduzione delle nuove generazioni è compensata dall’immigrazione.
È crisi demografica quando il numero medio dei figli scende al di sotto di 1,5 e rimane tale per lungo tempo. Gli squilibri generazionali assumono pesantezza. Le nascite calano sia per il basso tasso di fecondità sia per la contrazione numerica dei potenziali genitori. Si restringe la base della struttura demografica e aumentano le fasce di età avanzate. È una crisi che colpisce l’Italia a partire dal 1984. Il tasso di fecondità scende sotto 1,5 figli facendo sì che diventi, a metà degli anni ‘90, il primo Paese al mondo in cui gli under 15 superano numericamente gli ultra65enni. Vi è chi sostiene che, ‘abbondando’ in età adulta le generazioni nate quando il numero medio dei figli era sopra a due, abbia indotto a sopravvalutare il peso della popolazione in età lavorativa e a sottovalutare la crisi demografica, aggravata anche da un abbassamento della fecondità (da 1,44 del 2010 all’1,8 del 2024) e dall’entrata in età riproduttiva delle generazioni figlie della denatalità. È una crisi ‘figlia’, soprattutto, del crollo dei genitori, sia di quelli ‘capaci’ di esserlo sia di quelli che potrebbero esserlo. Si riducono le nascite e i futuri genitori. Quest’ultima riduzione ha peso sui potenziali lavoratori.
Si deve di garantire alle generazioni, divenute adulte e lavoratori, condizioni facilitanti i progetti professionali e di vita. Serve una politica di immigrazione rispondente alla domanda occupazionale, specie ove accusa carenza. Servono politiche che compensino con l’immigrazione, almeno in parte, gli squilibri tra popolazione attiva e popolazione in quiescenza e politiche generazionali e di genere che evitino che anche la fecondità dei cittadini stranieri si avvii verso bassi livelli.☺