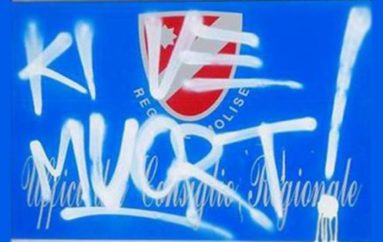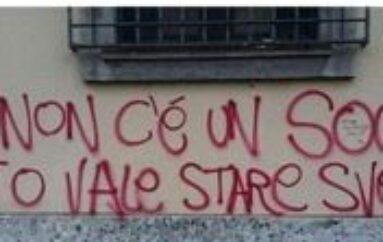Tammaro
Ci sono zone che, a prescindere dai confini amministrativi delle regioni, tendono a funzionare come un tutt’uno, cioè a sviluppare funzioni e relazioni che integrano tra di loro diversi comuni e province con una storia più lunga e persistente. Un percorso di strutturazione sociale che ha sedimentato sul territorio identità e pratiche comuni, comportamenti e paesaggi, invitandoci in non poche occasioni a ragionare in termini transregionali, opposti ai centralismi regionali tendenzialmente sempre più accentuati negli ultimi decenni.
Nella realtà effettiva l’Italia è formata da territori, più che da regioni, da una pluralità di sistemi territoriali che il regionalismo ha sostanzialmente trascurato e più volte mortificato. Senza esagerare nel determinismo geografico, spesso sono i fiumi, i monti o le valli a disegnare sistemi integrati dal punto di vista sociale, economico e culturale, dove l’incontro tra natura e insediamento umano ha generato territorio e paesaggio. Il paesaggio – scrisse Emilio Sereni – è il farsi di una società in un territorio.
Tra Molise e Campania, nell’Appennino meridionale, tra le province di Benevento e Campobasso, l’alta Valle del Tammaro è un comprensorio che si presenta in modo unitario, ricco di biodiversità, storia e cultura. L’elemento geografico comune è il fiume Tammaro che sorge nel territorio di Riccia, poco a nord della Sella di Vinchiaturo nei monti del Molise per poi dirigersi verso sud-ovest fino a sfociare nel Calore Irpino. Qui i vari comuni hanno subìto destini alterni dal punto di vista amministrativo, da una provincia all’altra e da una regione all’altra: quando fu istituita la provincia di Benevento nel 1861 i comuni molisani di Baselice, Campolattaro, Casalduni, Castelpagano, Castelvetere, Cercemaggiore, Circello, Colle Sannita, Foiano, Morcone, Pontelandolfo, Reino, San Lupo, Santa Croce del Sannio e Sassinoro passarono dalla provincia di Campobasso a quella di Benevento, quindi dal Molise alla Campania. Cercemaggiore tornerà in provincia di Campobasso nel 1927. Da Morcone e da Sepino comincia il Matese, uno dei più interessanti massicci montuosi dell’Appennino, ora avviato a diventare (finalmente) Parco Nazionale; anche in questo caso l’unità dovrebbe essere la montagna nel suo insieme, non semplicemente la somma dei due versanti afferenti a due regioni diverse. I confini amministrativi sul territorio non si vedono, o almeno non si dovrebbero vedere, per cui il sistema territoriale ha visto perpetuarsi le gravitazioni, le mobilità e le pratiche consolidate. Ha continuato ad essere un ecosistema caratterizzato da una varietà di ambienti con boschi, pascoli, e tratturi, gli antichi percorsi utilizzati dai pastori per la transumanza delle greggi e oggi sentieri ideali per il turismo sostenibile, percorsi che ci conducono nel diffuso patrimonio culturale, ambientale e gastronomico.
L’alimentazione è l’esigenza primaria delle comunità umane, il paesaggio è il contesto di vita, l’espressione della qualità e dell’identità di un territorio. Attorno al cibo si è sviluppato storicamente un insieme di economie, pratiche, valori e significati che oggi costituiscono una parte fondamentale del patrimonio territoriale, in particolare del patrimonio immateriale, come fattore dell’identità e del senso di appartenenza delle comunità locali, oltre che come risorsa economica dei territori. Il cibo costituisce così una chiave di accesso privilegiata per la rilettura del territorio, l’analisi del paesaggio, il ruolo dell’agricoltura, dell’ allevamento e delle attività di trasformazione e di consumo, per la ricostruzione delle culture e dei comportamenti sociali. Le pratiche alimentari si aggiungono alle feste, ai riti, ai simboli e ai saperi della storia e della sociabilità locale, formando quello che viene definito “patrimonio immateriale”. Specialmente nelle aree interne, la conoscenza e la messa a frutto di tale tematica può rappresentare una delle linee della possibile rigenerazione socio-economica e territoriale.
A partire da queste considerazioni, l’associazione Nuova Morcone Nostra – La Cittadella, in collaborazione con l’Università del Molise, ha avviato un programma di ricerca consistente in un censimento dei prodotti tradizionali, pratiche alimentari, ricette gastronomiche, riti e feste tradizionali. L’obiettivo è la redazione e pubblicazione di un atlante da utilizzare sia come strumento culturale di rafforzamento dell’identità locale e di attività sociali e didattiche, sia come base progettuale per un possibile distretto del cibo e della cultura o comunque entro una prospettiva ecomuseale. Ma l’aspetto più importante è la metodologia di tale progetto: una ricerca-azione condotta da gruppi locali con la supervisione scientifica dell’Università e il supporto organizzativo e logistico delle associazioni locali. L’attività è partita con il coinvolgimento delle associazioni del territorio, a partire dai municipi e dalle proloco, e con la diffusione di una scheda di rilevazione che potrà essere compilata anche da singoli cittadini e accompagnata eventualmente da rilievi documentari e/o fotografici, interviste e registrazioni video-audio. L’ambito territoriale comprende per il momento i comuni di Morcone, Sassinoro, Santa Croce del Sannio, Campolattaro, Pontelandolfo, Colle Sannita, Circello, Reino, Sepino, Cercemaggiore, San Giuliano del Sannio e Cercepiccola, tutti nell’Alto Tammaro, una zona a cavallo di Campania e Molise.
Secondo questa impostazione partecipativa, il percorso di ricerca è già un risultato, perché guardare il proprio territorio con la scheda in mano diventa per l’abitante un modo di generare conoscenza e consapevolezza, di attivare meccanismi di ri-conoscimento del patrimonio territoriale da parte degli abitanti e di presa di coscienza che le aree interne non sono il vuoto, il niente, ma un deposito di ricchezze dimenticate o inesplorate, che possono tornare utili per ritrovare una visione del futuro dei paesi e delle campagne che compongono gran parte dell’Italia. In questo senso, il ragionamento che abbiamo sviluppato sull’Alta Valle del Tammaro può essere applicato a tante altre situazioni infra e interregionali, suonando come un monito alla politica affinché la pianificazione e il governo del territorio tengano conto dei sistemi territoriali che la natura e la storia ci hanno consegnato.☺