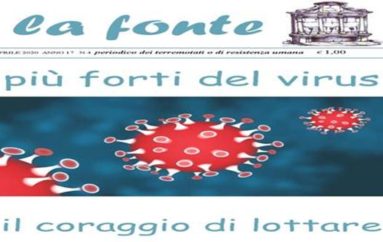Investire nella formazione
Si è documentato un diffuso analfabetismo funzionale, da non confondersi con un’altrettanta diffusa ignoranza nozionistica. Si può vivere senza grossi problemi se si confonde esteta con estetista o se si pensa che culturista sia una persona di cultura. Problemi si pongono quando la capacità di comprensione di ciò che si legge o di ciò che si ascolta è, invece, scarsa. Incorre in tali carenze il 35% degli italiani la cui età è compresa tra 16-65 anni contro, mediamente, il 26% degli europei comunitari. È un livello di sotto-istruzione indotto da investimenti fortemente carenti. Succede quando si ritiene che l’istruzione non sia da considerare un forte pilastro su cui si deve appoggiare lo sviluppo economico-sociale di lungo periodo di uno Stato. Emblematico è l’investimento previsto nella recente legge finanziaria.
L’obbligo scolastico fino a 14 anni fu introdotto dalla riforma Gentile nel 1923. Rimane lettera morta per la stragrande maggioranza degli studenti fino al 1962 quando viene approvata la legge di riforma della scuola media, nonostante che la Costituzione abbia sanzionato tale obbligo nel 1948. Va detto che interventi normativi di varia natura e forza, a partire dagli anni Cinquanta, contribuiscono a ridurre gli analfabeti. Si passa dal 13% all’8% nel 1961e all’1,5% del 2001. Aumentano, nel frattempo, anche le persone in possesso di un titolo di studio. Era diplomato il 3% e laureato l’1% della popolazione nel 1951. Sono tali, rispettivamente, il 25% e il 7% nel 2001. Sono in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore il 65% nel 2021e il 27% di un diploma di laurea. I laureati europei sono, mediamente, il 42%. È un divario pesante e penalizzante.
Va ricordato che, a partire dalla ricostruzione al boom economico, il livello di istruzione primaria e secondaria si è incrementato, non si è, però, incrementato quello post-diploma scuola superiore. Forse, allora, non si è potuto cogliere la necessità di affiancare a uno sviluppo economico e sociale di lungo termine una forte formazione terziaria. Vi hanno fatto ostacolo anche le condizioni economico-sociali. Ciò ha reso debole l’Italia dentro la crescente competizione accademica internazionale.
Studiare, attrezzandosi culturalmente e professionalmente, è il migliore investimento. Facilita l’accesso al lavoro e garantisce una migliore remunerazione. L’11% degli italiani tra 18-24 anni abbandona gli studi, in misura più pesante nel Sud-Italia. È una perdita di potenziali capacità. Una ricerca pubblicata da Nature mostra che nel decennio 2010-2020 quasi 1.000 italiani con laurea e dottorato, rilasciati da università italiane, hanno trovato lavoro in università americane. Il 35% di tali università sono tra le più prestigiose. Vi accedono meno del 10% dei docenti americani. Il sistema italiano di formazione terziaria licenzia docenti accademici e ricercatori preparati e capaci. Propone però loro offerte di lavoro poco attrattive e poco rimunerative. Scarsa è la presenza di docenti comunitari o extra-comunitari nelle università italiane. Sono l’1%. Bassa è l’attrazione per gli studenti stranieri. Si è passati da 40mila a 80mila: il 6% contro il 12% dei Paesi europei.
Manca o, forse, è ancora debole la presa di coscienza della necessità di investimenti cospicui e continui nella formazione accademica e terziaria di modo che i vantaggi siano di lungo termine. Non si coglie ancora o lo si coglie debolmente che un sistema formativo competitivo incide positivamente sulla crescita economica di un Paese, crea posti di lavoro e favorisce l’innovazione tecnologica. La spesa per la formazione terziaria tra il 1995-2020 è stata l’0,8% del PIL. Essa è passata in Germania, Francia e Regno Unito dall’1% all’1,5%.☺