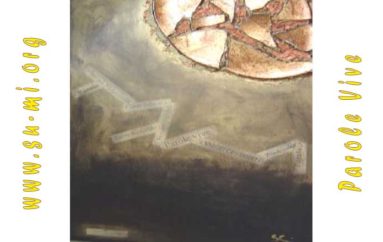Pittore tra oriente e occidente
Giulio Aristide Sartorio nacque a Roma l’11 febbraio 1860 da una famiglia originaria di Novara. Avviato dal padre, il pittore Raffaele, alla pittura, ottenne fin da subito numerosi consensi: già nel 1879 fu in grado di mantenersi uno studio in via Borgognona. All’età di 20 anni, grazie all’ amico A. Sommaruga, fece la conoscenza di d’Annunzio, Carducci e Scarfoglio. Iniziò a collaborare alla Cronaca bizantina, rivista quindicinale a carattere letterario-sociale-artistico. Dopo aver viaggiato in tutta Europa alla fine degli anni ’80 si recò in America Latina, nel Medio e Estremo Oriente. Il soggiorno a Parigi, condiviso con Francesco Paolo Michetti, durante il quale ebbe modo di studiare da vicino l’opera dei paesaggisti francesi, favorì il sorgere di un interesse per la pittura naturalistica e per la raffigurazione degli animali.
Entusiasmo preraffaellita
Negli anni ’90 la pittura preraffaellita lo entusiasmò al punto da scrivere due saggi: uno su Edward Burne-Jones e l’altro su Dante Gabriel Rossetti. Nel 1896, di ritorno da Weimar dove era stato ospite dal Granduca Carlo Alessandro, fondò il gruppo “I Venticinque della Campagna Romana” con Enrico Coleman, Onorato Carlandi e A. Reggio. Nel 1915 partì per la guerra ma, ferito a Lucinico, fu fatto prigioniero per due anni a Mauthausen. Liberato per intervento di Benedetto XV tornò al fronte ma solo per dipingere la vita dei soldati. Dopo il conflitto si recò nuovamente in Egitto, Siria e Palestina realizzando numerosi paesaggi. Nel 1930 partecipò per l’ultima volta alla Biennale di Venezia. Morì a Roma nel 1932.
Luce di un futuro luminoso
“Per il Fregio del Parlamento Sartorio si vantava tranquillo di aver dipinto in 930 giorni 285 figure di uomini ed animali su 450 metri di tela. Teneva questa tela avvolta sopra un rullo dritto e la tela dipinta faceva ogni settimana un passo”. Così, alla morte dell’artista, scrive Ugo Ojetti sul Corriere della Sera il 6 ottobre del 1932.
Sartorio si prepara puntigliosamente alla realizzazione dell’opera che, nel rispetto della bi-dimensionalità della parete, celebra epicamente la storia d’Italia, dall’età comunale al Risorgimento: studia al British Museum di Londra i marmi del Partenone e i Trionfi di Andrea Mantegna ad Hampton Court. Sperimenta soluzioni nuove sia nella tecnica pittorica sia nella composizione: allo studio dei modelli dal vero alterna l’uso pionieristico della fotografia. Per l’abbozzo dell’opera sulle grandi tele proietta diapositive dei bozzetti e disegni già elaborati, componendo una complessa coreografia di 200 figure. La preparazione e l’esecuzione dell’opera impegnano l’artista dal 1908 al 1912. L’architetto della Nuova Ala del Parlamento è Ernesto Basile che designa Sartorio, non senza polemiche, “proprio artista di fiducia”.
Nel lato rettilineo dell’Aula sono illustrate le vicende epiche del popolo italiano ed il Risorgimento. Il sole della libertà occupa il centro della figurazione; ai lati, scorci arditi e nodi plastici di corpi scultorei avviluppati danno forma alle lotte contro i barbari e alle Furie; a queste figure dalla valenza negativa e violenta si contrappone il giovane popolo italiano con i suoi fulgidi valori positivi.
Nell’emiciclo dell’Aula la complessa iconografia del Fregio e la sontuosa pittura celebrano i valori costitutivi della tradizione del popolo italiano. Al centro l’Italia, giovane donna “dall’espressione serena” su una quadriga retta dai Dioscuri; alle sue spalle un disco di luce simboleggia il luminoso futuro. La superficie di fondo della figurazione è costituita da un’alta zoccolatura marmorea e fa da cornice, in uno spazio ristretto in profondità, alle immagini che si animano e si staccano dal fondo. Il colore, tenuto nei toni bassi delle terre, dà il senso della vita che si anima: la civiltà del popolo italiano dopo l’unità d’Italia.☺