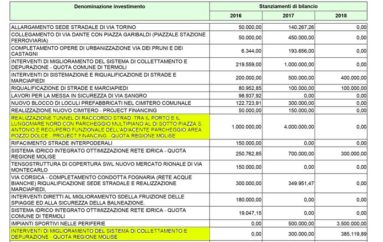Quando la lotta paga
Viviamo in un’epoca in cui prevale l’indifferenza e il qualunquismo, il senso di impotenza e l’ineluttabilità di una direzione di marcia sulla quale sembra impossibile incidere, orientata dal potere economico che sembra avere definitivamente soffocato il profilo nobile della politica e gravemente inquinato la prospettiva democratica.
La crisi ambientale è una delle questioni che ci ha consegnato il Novecento, secolo globale dalle enormi contraddizioni, con i suoi straordinari progressi intrecciati alla violenza delle guerre, alle disuguaglianze nei diritti e ad un crescente dominio dell’uomo sulla natura, che ha finito per rivoltarcisi contro. Il rapporto uomo-ambiente è sempre stato problematico nella prospettiva storica, ma il XX secolo ha significato un fortissimo cambio di scala, un aumento senza precedenti del ritmo di sfruttamento delle risorse naturali e la comparsa di nuove forme di inquinamento. Il nucleare è una di queste, insidiosa e invisibile, difficile da controllare e dotata di un potere distruttivo incalcolabile, come dimostrato dagli avvenimenti degli ultimi settant’anni: dalle bombe atomiche sganciate dagli americani nel 1945 sulle città giapponesi di Hiroshima e Nagasaki, agli incidenti delle centrali nucleari di Three Miles Island (Usa, 1979), Chernobyl (Urss, 1986) e Fukushima (Giappone, 2011). La questione nucleare è stata anche il terreno decisivo su cui ha preso forma in Italia l’ambientalismo contemporaneo, che proprio grazie all’opposizione alle nuove centrali è passato da una impostazione essenzialmente elitaria e culturale a una dimensione politica di massa.
Questa svolta è avvenuta negli anni ’70 del secolo scorso, e Termoli rappresenta a livello italiano una delle testimonianze più significative di questo mutamento di prospettiva. Nel periodo della prima crisi petrolifera e della conseguente austerity, del post Sessantotto, del compromesso storico e degli anni di piombo, nel quale irruppero anche tragedie ambientali come quella di Seveso, il governo italiano scelse il Basso Molise come area dove costruire una delle venti centrali nucleari previste dal Piano energetico nazionale approvato nel 1975. La reazione contraria delle comunità e delle istituzioni locali fu immediata, ma nel novembre del 1978 il Ministro dell’Industria, il democristiano Carlo Donat Cattin, firmava un decreto che confermava l’insediamento di una centrale elettronucleare in Molise. Era una decisione dirigista e autoritaria, che non teneva conto del parere negativo espresso dalla Regione Molise, peraltro governata dallo stesso partito e guidata dal termolese Florindo D’ Aimmo.
Nel giro di un mese i diversi soggetti della società civile, forti anche del sostegno delle istituzioni locali, riuscirono ad organizzare una vasta mobilitazione che sfociò in un imponente corteo per le strade di Termoli la mattina del 2 dicembre 1978. Sfidando il vento freddo che soffiava dal mare, in una città militarizzata (siamo ancora nell’anno del tragico attentato terroristico a Aldo Moro e alla sua scorta), ma in un clima alla fine sereno e senza incidenti, più di 8.000 persone gridarono la preoccupazione e la ferma contrarietà di un’intera regione.
La vicenda è ben raccontata e descritta in un libro scritto cinque anni fa da Aldo Camporeale e Enzo Gallo e pubblicato dall’editore Solfanelli di Chieti con un titolo che infonde speranza, Quando il Molise fermò il nu- cleare, e un sottotitolo esplicativo: “Quarant’ anni di lotte per l’ambiente a Termoli e nel Basso Molise”. In esso emergono voci e simboli di quella importante manifestazione, sintetizzati dalla foto di un giovane che apriva il corteo, vestito da contadino e con la falce della morte in spalla; una mobilitazione che coinvolse gli agricoltori con i loro trattori e gli studenti con i loro slogan creativi, allargandosi a tutti gli altri strati sociali e alle associazioni del territorio.
Fu anche grazie alla riuscita di questa ampia mobilitazione che il decreto Donat Cattin non venne convertito in legge e che successivamente il Molise sarà escluso dall’elenco dei siti per l’attuazione della parte nucleare del piano energetico. Insieme alla grande manifestazione nazionale del 1977 a Montalto di Castro (Viterbo), sede di un altro impianto nucleare in costruzione, quella di Termoli può essere considerata una delle tappe decisive del movimento antinucleare, che porterà al blocco del piano nucleare in Italia, poi sancito dal referendum popolare del 1987 grazie al quale gli italiani si espressero contro questa forma di produzione energetica.
Successivamente, come sappiamo, il dibattito sul nucleare è periodicamente riemerso: dalla “Strategia energetica nazionale” dei governi berlusconiani, che prevedeva nuovamente la realizzazione di impianti, al referendum del 2011, che ne confermava invece il rifiuto popolare; fino all’attuale ripresa della discussione che oscilla tra diniego pressoché unanime del nucleare tradizionale e possibilismo di alcuni per il cosiddetto nucleare “di quarta generazione”; mentre è rimasta irrisolta la grave questione che periodicamente torna a far parlare di sé, cioè quella relativa alla creazione di un unico e definitivo deposito nazionale per i rifiuti radioattivi frutto delle centrali attive nel passato. Contro la localizzazione di un simile impianto sono attualmente in lotta i territori della Tuscia, anche qui con una significativa convergenza tra cittadini e istituzioni locali.
La ricostruzione della grande mobilitazione contro il nucleare avvenuta in quel di Termoli nel clima acceso ma ancora democraticamente fervido degli anni ’70, ci invita dunque a riflettere su una deriva postdemocratica, che si è venuta profilando negli ultimi decenni, e sul destino della nostra democrazia, che proprio sul terreno locale può sperimentare pratiche e forme di rinascita, di riconnessione tra istituzioni e cittadini, tra governo e territorio. Il libro di Camporeale e Gallo, che merita ancora oggi una più ampia lettura, costituisce un significativo contributo alla conoscenza della storia ambientale del Molise, e al tempo stesso tocca alcuni tra i problemi più impellenti del nostro tempo, come il rapporto uomo-ambiente e quello altrettanto significativo tra cittadini e istituzioni. È anche la testimonianza dell’importanza che nella società rivestono l’associazionismo e tutte le forme di impegno e di organizzazione collettiva. Solo così, unendoci e lottando, possiamo sperare che gli abitanti e i territori tornino a contare davvero nelle scelte che li riguardano. Quando la lotta paga, la società è più civile e il sistema si mantiene più democratico.☺