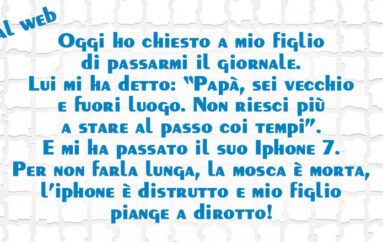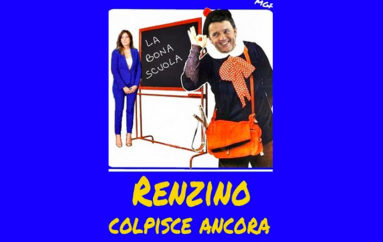Scuola: dall’integrazione all’inclusione
Ripartiti da qualche settimana i TFA (per i non-addetti ai lavori, i percorsi predisposti dal MIUR per conseguire la specializzazione richiesta agli insegnanti di sostegno), si torna a riflettere sul significato e le attuali modalità di attuazione dell’ integrazione scolastica, proseguendo un dibattito antico che, passando per l’attenzione al linguaggio e alla terminologia, arriva alla sostanza e tocca tutto l’impianto pedagogico dell’inserimento degli alunni con difficoltà.
È una realtà, ci sono molte ragioni che spingerebbero a “cambiare” perché, allo stato attuale delle cose, si comincia a sostenere da più parti che la figura e il ruolo dell’insegnante di sostegno abbia ormai fatto il suo tempo.
Proviamo a gettare dei semi di riflessione su uno degli aspetti più delicati del sistema scolastico. La delega all’ insegnante di sostegno è diffusa, praticata senza che ci siano vere azioni di contrasto. E per di più, attualmente, nella logica dell’integrazione, l’impegno richiesto è troppo focalizzato su ciò che è patologia, su ciò che non funziona.
Da tempo l’Organizzazione Mondiale della Sanità invita le istituzioni ad occuparsi in termini mirati non solo degli alunni con disabilità, ma di tutti gli alunni che si trovano, per una serie svariata e differenziata di motivi, con delle fragilità che rendono più difficile il loro percorso di apprendimento e di sviluppo personale. Si tratta dell’imponente esercito delle persone con Bisogni Educativi Speciali (BES), che comprendono anche gli alunni che presentano disturbi nell’apprendimento (DSA), o che sono penalizzati a causa di un contesto di vita molto difficile.
Alla luce della nuova consapevolezza con cui si cerca di affrontare questa realtà eterogenea e cangiante, gli insegnanti incontrano spesso molte difficoltà nella gestione di classi tanto variegate. Più che un ostacolo, tuttavia, un’opportunità: quella di cercare approcci nuovi, e di avviare la transizione dalla didattica “speciale”, riservata agli studenti con disabilità, ad una speciale qualità della didattica per tutti, una didattica capace di essere individualizzata, personalizzante, diversificata, flessibile, una didattica che sia, in una parola, inclusiva.
Il paradigma dell’inclusione supera quello dell’integrazione, perché lo comprende ma non vi si deve identificare. Anzi. Intanto l’inclusione così pensata non può avvenire estendendo all’area dei BES lo stesso dispositivo adottato per l’ assegnazione degli insegnanti di sostegno, che si fonda sul binomio “certificazione/assegnazio- ne” dell’insegnante specializzato, un meccanismo che sembra ormai arrugginito, e non in grado di rispondere alle reali esigenze del bambino, o del ragazzo. In effetti, mentre i manuali utilizzati per la formulazione delle diagnosi sono ancora tutti focalizzati sulla ricognizione delle patologie, da tempo l’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda l’utilizzo di strumenti diagnostici centrati sulla persona e sul suo rapporto con il contesto ambientale (sociale, culturale, spaziale).
Cosa fare? Le posizioni sono diverse. Alcuni ritengono che sarebbe sufficiente intervenire con una serie di azioni mirate, nel rispetto del quadro esistente. La strada degli interventi mirati potrebbe arrecare qualche beneficio, ma si rimane nel vecchio schema dell’integrazione, senza scalfirlo. Altri, di posizione radicale, puntano addirittura all’abolizione della figura dell’insegnante di sostegno, portando così alle estreme conseguenze l’idea forte della responsabilità collegiale. Rispettabile, ma discutibile come posizione: annullare completamente l’idea di una specializzazione potrebbe comportare dei rischi. Altri ancora, infine, abbracciano l’idea (ancora indefinita ma, probabilmente, la più affascinante) di un modello nuovo, che preveda una “moltiplicazione” degli insegnanti specializzati, diversificandoli in specializzati per i disturbi specifici di apprendimento, specializzati per operare con gli alunni che presentano severe penalizzazioni sociali, specializzati per operare con gli studenti stranieri… e così via. Una moltiplicazione intelligente, mirata, delle figure “di sostegno”.
Un modello costoso, sicuramente, ma che potrebbe essere affrontato se venisse sollevato con forza il problema enorme delle elemosine statali di cui vive la scuola pubblica italiana. Un modello che richiederebbe il coraggio di destinare all’istruzione soldi e risorse di cui non abbiamo mai goduto e che, invece, metterebbero improvvisamente al centro dell’agenda, finalmente, la scuola, il bambino, l’educazione, la crescita. E il mestiere dell’insegnante.
Forse è arrivato il momento di ripensare seriamente, in maniera robusta, il cammino fatto fin qui. Non per deprezzare ciò che si è costruito, ma per analizzare con sapienza e lucidità i punti forti e quelli di debolezza di questo percorso. I bambini, i ragazzi, sono persone. Ogni persona ha i suoi bisogni, le sue specificità, le sue fragilità. È tempo che la didattica si “chini” sul bisogno del singolo, sul bisogno di ciascuno e di tutti, adottando una flessibilità che finora non ha avuto.
Possiamo provare a rifletterci su.☺