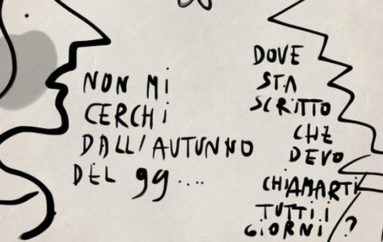Reddito di cittadinanza
Scriveva Ernesto Rossi, autore con Altiero Spinelli e Eugenio Colorni del Manifesto di Ventotene, confinati nell’isola pontina, nel volume Abolire la miseria (1942): si combatte “la povertà non con i trasferimenti monetari, ma dando a tutti i cittadini, qualora si vengono a trovare in condizioni di bisogno, la garanzia di poter disporre di quantità minime di beni e di servizi primari come l’ alloggio, il cibo, il vestiario”. Va subito chiarito che miseria e povertà non sono condizioni simili. Miseria allude a una condizione di estrema indigenza in cui mancano i beni e i servizi essenziali, mentre povertà ha una connotazione più relativa. Chiama in campo le difficoltà che impediscono di garantire a se stesso e ai propri familiari una vita dignitosa. Si fa distinzione tra povertà assoluta e povertà relativa. La miseria è stata ridimensionata. La povertà, invece, è ancora presente ed è aggravata dalla pesante situazione economico-sociale.
Il Reddito di cittadinanza (Rdc) viene erogato da quasi tre anni (Legge 18 gennaio 2019, n.4). L’INPS ne ha diffuso, di recente, i dati aggiornati a marzo 2022. Esso consiste in un contributo economico erogato ai cittadini italiani o comunitari o a chi è lungo soggiornante in Italia. Questi ultimi vi devono risiedere da almeno 10 anni. Si deve disporre di un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) che non superi 9.360 euro annui. Ogni nucleo familiare può presentare solo una domanda, per cui succede che il numero di persone coinvolte sia maggiore delle domande accolte. Obiettivo del Rdc è quello di accompagnare le persone fuori dalla povertà. Si individua nel lavoro-posto di lavoro lo strumento forte per tale fuoriuscita. È una visione semplicistica poiché il lavoro da solo è uno strumento debole. Le povertà (e, quindi, anche la povertà economica) sono tante e diverse e non tutte sono aggredibili o lo sono solo parzialmente solo se si dispone di un adeguato salario che il lavoro dovrebbe garantire. Illuminante è in proposito la discussione sul salario minimo. Pesantezza hanno assunto in questo momento la povertà da lavoro e la povertà di lavoro. Il Rdc può contribuire a ridurre il peso della povertà da lavoro (insufficienti/bassi/discontinui salari, discontinuità lavorativa…). Esso è, però, debole contro la povertà di lavoro. Non se ne discute in questa sede. Condurre fuori dalla povertà economica impone di garantire un lavoro dignitoso e un salario adeguato e la loro continuità nel tempo di modo che si possa disporre di un quantum di risorse monetarie che garantiscano una vita dignitosa per sé e per la propria famiglia nel proprio contesto di vita.
Dati statistici
Il Rapporto INPS offre un quadro abbastanza preciso circa il numero e i profili dei beneficiari del Rdc. Esso ne evidenzia la debolezza economica, attribuibile alla carenza reddituale e ai bassi salari percepiti e legati al lavoro prestato. Hanno usufruito nei primi tre anni di almeno una mensilità del Rdc o della Pdc (pensione di cittadinanza, variante del Rdc che viene erogata a nuclei familiari composti da una sola persona con almeno 67 anni di età) 2,2 milioni di famiglie, pari a quasi il 9% delle famiglie italiane. Sono quasi 4,8 milioni le persone viventi in tali nuclei. La spesa totale erogata (aprile 2019/marzo 2022) è stata di circa 23 miliardi, di cui 7,1 miliardi nel 2020 e 8,8 miliardi nel 2021. La spesa sostenuta nei tre mesi del 2022 è pari 2,1 miliardi. Hanno ricevuto nel mese di marzo 2022 il Rdc 1,2 milioni di famiglie, pari a 2,7 milioni di persone. Costoro sono circa la metà dei poveri assoluti (dati Istat). L’importo medio mensile è di circa 550 euro per nucleo familiare percettore (770 euro per il Rdc e 248 per la Pdc). Hanno percepito il Rdc nel 2022 41,8mila cittadini europei e 90mila cittadini extracomunitari. Il 69% dei nuclei familiari percettori di Rdc risiede nel Sud-Italia: 12% in Campania, 11,4% in Sicilia, e il 9,8 in Calabria. Lo percepisce l’1,1% in Valle d’Aosta, l’1% in Veneto e lo 0,6% in Trentino Alto Adige. Gli importi vanno da 430 euro in Trentino a 612 euro in Campania. Più in generale, la media del Nord-Italia è di 486 euro, quella del Centro-Italia 513 euro e quella del Mezzogiorno 581 euro. Il 25% ha meno di 18 anni, il 28% ha almeno 50anni. Sono extra-comunitari l’11% dei beneficiari del Rdc.
La dimensione media dei nuclei familiari si va contraendo: da 2,45 nel 2019 a 2,35 nel 2020, a 2,23 nel 2021 e a 2,21 nel 2022. Incidono su tale contrazione il declino demografico, le varie forme di povertà e i requisiti necessari per accedere al Rdc. Si veda la penalizzazione dei nuclei familiari con minori, stante il basso peso loro assegnato nella scala di equivalenza. Penalizzano gli immigrati a cui si richiede una residenza almeno decennale in Italia. Sono penalizzati i nuclei familiari numerosi e con figli minori. Sono, poi, possibili comportamenti opportunistici: suddividere i membri di una famiglia in più nuclei familiari distinti per poter disporre dei requisiti richiesti. Poco tutelate le povertà dei minori e quelle dei 50-60enni non ancora pensionati. Molti di costoro sono poveri.
Rdc e lavoro
Molti fruitori del Rdc, pur disponendo di un lavoro, sono lavoratori deboli. Se consideriamo chi lavora, per almeno 11 mesi in un anno, ed ha ricevuto il Rdc (escludendo la pensione di cittadinanza), nel 40% di tali nuclei familiari ne beneficia almeno un lavoratore. Il 30% di costoro ha un’età compresa tra 18-49 anni e il 18% va oltre 50 anni. La loro debolezza sta nel fatto che sono occupati, di solito, in un lavoro dipendente per 6/7 mesi nel corso dell’anno, hanno contratti spesso a tempo determinato, a tempo parziale o ‘nebulosi’ e la loro retribuzione media è di circa 6mila euro. Elevata è la presenza di tali lavoratori tra gli extracomunitari. Questi dati segnalano una consistente presenza, tra i percettori di Rdc stabili, di lavoratori deboli: bassi redditi, occupati in lavori di breve durata (anche poche ore) o occasionali e precari. Molti lavorano poco o hanno smesso da poco di lavorare. Il 30% ha un’età compresa tra 18-49 anni. Tale percentuale è stata calcolata considerando tutte le persone viventi tali fasce di età, compresi anche gli invalidi o chi ben difficilmente potrebbe prestare una qualche attività lavorativa.
Il Rapporto INPS segnala, a proposito della propensione a offrire lavoro ai beneficiari del Rdc, una lieve riduzione attribuibile anche all’andamento generale dell’economia post-pandemica e all’offerta di lavoro nero. Vi ha inciso nel 2020 e 2021 anche la perdita dei requisiti economici (incremento del reddito/patrimonio del nucleo familiare) e il controllo ispettivo sul lavoro nero.
Rimane in campo il tema della relazione tra Rdc e lavoro. Se ci si pone l’ obiettivo di aumentare la quota di adulti beneficiari che lavorano, pur sapendo che sarà sempre inferiore al 100%, sarebbe necessario – come ha suggerito la Commissione Saraceno sul Rdc – ridurre l’alta tassazione implicita gravante sul reddito da lavoro e passare dall’80-100% attuale al 50%) e, forse, ridurre l’importo del Rdc per la persona sola, aumentando nello stesso tempo la scala di equivalenza.☺