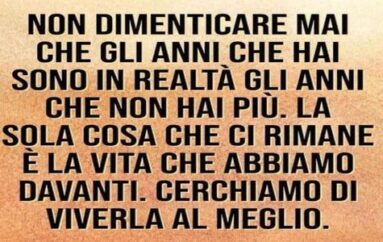Quell’è omo!
“Quell’è omo!”: così si sente rispondere – in dialetto romanesco – Delia, la protagonista del film C’è ancora domani, alla sua osservazione riguardo al compenso del suo collega, un giovane apprendista che, al primo giorno di lavoro, riceve una paga giornaliera superiore alla sua soltanto perché è di sesso maschile!
La situazione, immaginata e rappresentata nel film di Paola Cortellesi, ambientato nell’Italia del 1946, non è dissimile da quella odierna; infatti si continua a parlare di sperequazione nei salari tra i dipendenti, vale a dire le donne vengono ancora oggi retribuite meno degli uomini.
C’è un’espressione inglese che riassume sinteticamente la tematica – complessa – che riguarda la disparità di trattamento che le donne, in gran parte, subiscono in materia di compenso. Si tratta di gender pay gap [pronuncia: gender-pei-ghep], tre parole che sottendono altrettanti concetti. I tre termini dell’espressone traducono nel loro insieme ‘divario salariale di genere’: gap indica infatti la frattura o separazione; con il verbo pay – letteralmente ‘pagare’ – si intendono retribuzione o stipendio; per essere esatti il verbo pay può essere sostituito dal sostantivo wage [pronuncia: ueig] che traduce ‘salario’, e l’alternativa alla locuzione diventa gender wage gap. Ma il termine che chiarisce l’intera espressione è gender, che ne interpreta l’ essenza: la disuguaglianza sta nel genere!
“La guerra mai dichiarata al sesso femminile, che ha segnato fin dal suo atto fondativo il dominio di una comunità storica di uomini, non poteva non lasciare tracce durature nella vita degli individui e delle società, nella cultura e nelle istituzioni della vita pubblica, nelle abitudini quotidiane e nella storia dei popoli”. Lea Melandri, nel suo Amore e violenza – ristampato recentemente – ricorda come ci siano voluti decenni di riflessioni, contestazioni, lotte – ovviamente da parte delle donne – per modificare almeno in parte un assetto della società in cui continua a predominare l’elemento maschile e che riserva alle donne ruoli secondari o esclusivamente di cura (della famiglia, dei bambini, degli anziani).
Purtroppo la storia dell’umanità, e del mondo occidentale in particolare, non ha visto protagonista il genere femminile: sempre secondo la citata autrice, “le donne vengono inserite in un sistema e in una cultura elaborata senza di loro, nel senso che quel sistema produttivo e quella cultura sono nati in una società fondata su ben precisi rapporti di produzione, su una ben precisa nozione del ruolo sociale maschile e femminile”.
La persistenza di una disparità retributiva deve essere imputata, come suggerisce la sociologa Chiara Saraceno, alla concentrazione di impiego delle donne in quei settori che offrono maggiori possibilità di conciliazione tra le ore di lavoro e le esigenze personali e familiari, vale a dire l’ insegnamento, il settore tessile o dei servizi alla persona; tutti questi ambiti, a prescindere dall’ identità sessuale del prestatore di lavoro, vengono remunerati meno rispetto ad altri. Inoltre le donne stesse sono vittime di disuguaglianza in quanto tra di loro non sono molte quelle che accedono a livelli di carriera o posti di dirigenza i quali solitamente vengono ricoperti da uomini: il risultato è quello di vedere donne in ambienti di lavoro a loro destinati, riproducendo quello status della società che per secoli è stato considerato legittimo.
In un breve saggio del 1941 (Per- corsi di pace durante una incursione aerea) Virginia Woolf, intellettuale profonda e preoccupata dalla tragedia della guerra (!), rifletteva su quella che, secondo lei, era l’indole dei due sessi: ‘hitle- rismo inconscio’, vale a dire desiderio di dominio, di aggressione – per gli uomini – mentre le donne, che preferiscono specchiarsi nelle vetrine dei negozi, vengono definite ‘schiave che cercano di rendere schiavi gli altri’. Oltre a quella di Virginia Woolf molte altre sono state in questi decenni le riflessioni e le critiche verso le responsabilità delle donne stesse circa la loro condizione di emarginazione sociale, un “destino che accomuna la natura e la donna, al dominio che su di esse hanno imposto le istituzioni della vita pubblica, i dogmi e i rituali della religione, le costellazioni di immagini e simboli di cui sono impregnati i linguaggi più diversi della civiltà”.
La strada sembra ancora lunga da percorrere, ed anche in salita: le leggi, le misure giuridiche di contrasto alla discriminazione in base al genere, le multe ai datori di lavoro, tutte queste azioni ancora non sono in grado di sconfiggere l’imposizione di questo modello di società di cui ancora siamo eredi. “Sugli stereotipi di genere non si è fondato solo il dominio dell’uomo sulla donna, o della storia sulla natura, ma anche la divisione sessuale del lavoro, la falsa reciprocità tra quello che viene considerato il regno della donna nella casa e dell’uomo nella sfera pubblica” (L. Melandri).☺