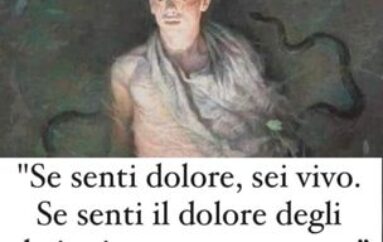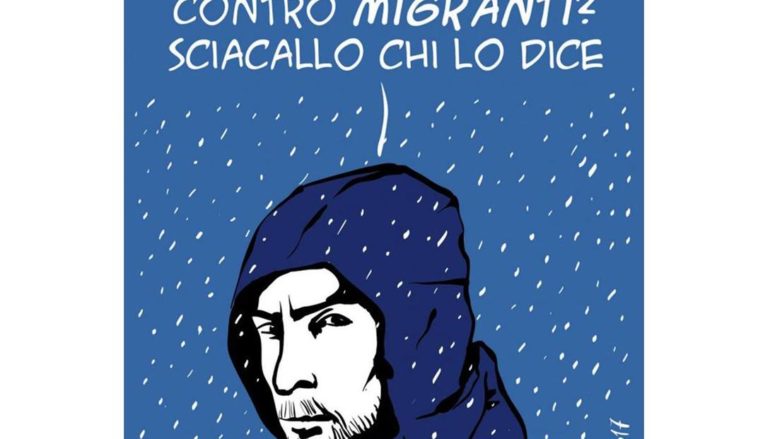
Casone di Casacalenda: Custodialismo, mandato sociale, etica in Comunità
Dall’interno, quotidianamente, giocando a rimpallare facendo un passo fuori, cambiando prospettiva, ci si osserva presi dentro meccanismi e ripetizioni, inconsci, culturalmente ereditati: la Comunità è anche questo. Il mandato sociale colloca l’istituzione di cura nella posizione d’incrocio, dove si innesta il discorso terapeutico su quello della custodia: lo sappiamo, è storia vecchia, e le esplosioni progressive non hanno fatto che ricollocare il discorso su un piano diverso, generando gli anticorpi contro il germe della Politica. Così spesso si mescola l’inerzia che è interna all’individuo (operatori e ospiti ne condividono l’essenza, in un verso dispositivo democratico: l’inerzia ci appartiene e le apparteniamo) con quella inerzia istituzionale che sotto la patina di una volontà di incidere con la cura cela la necessità di scavare posizioni di controllo, di limitazione, sacche di u-topia (non luoghi, insomma).
La sfida è cambiare il senso dell’utopia, dal non-luogo all’immaginazione di un luogo che non esiste ancora; dalla conservazione alla rivoluzione, senza la paura di rispolverare termini e idee lontane. In fondo la Comunità ha il compito di costituire luoghi insoliti, inediti, abitabili soggettivamente; quando cede al senso comune, è un ripetitore di buon senso, uno dei peggiori posti che possa capitare di frequentare. Lì il mandato della società civile fa risonanza con l’inconscio individuale e di gruppo, che in ossequio al principio di piacere limita le scosse esterne, le perturbazioni del sistema.
Spesso parliamo di etica psicoanalitica, ma altrettanto frequentemente dimentichiamo di chiarirne i termini, scadendo nella retorica della lotta di civiltà: altro non è, questa etica, che un modo di prendere posizione, non già la somma degli interventi di natura psicoanalitica. La Comunità terapeutica è il luogo delle scelte, dove la scelta fa la differenza, segna uno scarto, determina ripercussioni e modifiche, spezza l’inerzia della coazione. Non un’azione qualsiasi, né una pratica fine a se stessa; piuttosto, la tolleranza verso il buco che abita il cuore della conoscenza e del soggetto, quella mancanza che ci attiva e ci spinge verso l’ignoto: a partire da quel buco, dalla mancanza, si possono scatenare i conflitti dialettici che spalancano le porte di configurazioni nuove, nuovi spazi di abitabilità. Non una scelta centralistica, un decisionismo vuoto, ma un’etica delle scelta, e il coraggio che sostiene l’incontro con l’alterità più irriducibile.