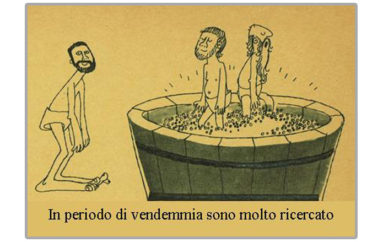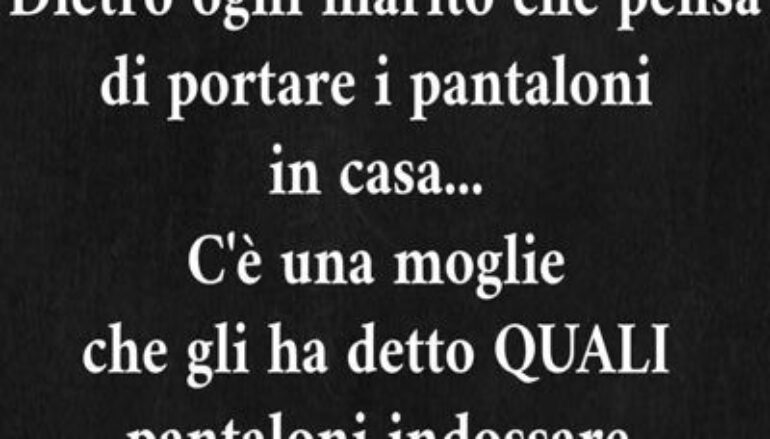
E’ sempre reato rubare?
La recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 40685 del 6 novembre 2024, sollecita una riflessione profonda su una questione che riguarda la vita quotidiana, sollevando interrogativi morali e giuridici di straordinaria rilevanza: è giustificabile un furto commesso per necessità?
Il caso in esame riguarda una donna senza fissa dimora che, spinta dalla fame, aveva rubato beni di prima necessità in un supermercato. I giudici hanno qualificato tale condotta criminosa come “furto lieve per bisogno”. Questa decisione offre uno spunto interessante per una complessa riflessione che intreccia diritto e moralità, invitando a interrogarsi: quando il furto non è motivato dalla brama di profitto, ma dalla necessità di sopravvivenza, può essere trattato come un crimine?
Sul tema sono stati versati fiumi di inchiostro da grandi pensatori della filosofia e della giurisprudenza. Platone, ne La Repubblica, nel delineare lo stato ideale (il cosiddetto “comunismo platonico”), affermava che l’origine del male risiede nella proprietà privata, che genera disuguaglianze e alimenta l’egoismo. Secondo il filosofo greco, infatti, se le risorse fossero distribuite equamente, non ci sarebbe motivo per il furto, che nasce dal desiderio insoddisfatto di possedere ciò che manca. La disuguaglianza economica, che oggi caratterizza gran parte delle nostre società, sembra dare ragione a Platone, poiché molte persone si trovano a commettere atti illegali per sopravvivere in situazioni di estrema povertà. Anche Dostoevskij, in Delitto e Castigo, scriveva: “Il male non è sempre tale, e la legge spesso si trova a giudicare quello che è, più che un crimine, una necessità”. Le parole dello scrittore russo suggeriscono che la moralità di un atto dipende non solo dall’intenzione, ma dalla condizione psicologica e sociale di chi lo compie.
Se un furto è frutto di una disperazione che non lascia alternative, è davvero un crimine o, invece, rappresenta un grido di aiuto per un sistema che non offre risorse sufficienti per una vita dignitosa per tutti? Questo è il punto!
Anche Cesare Beccaria, nel suo celebre Dei Delitti e Delle Pene, sosteneva che la legge, pur essendo fondamentale per garantire l’ordine sociale, non può ignorare le difficoltà reali degli individui. La giustizia, secondo Beccaria, non deve basarsi esclusivamente su una rigida applicazione delle norme, ma anche sulla comprensione delle condizioni di vita di chi trasgredisce. Il divieto di rubare è anche presente nei Dieci Comandamenti. Papa Francesco, nel ciclo di catechesi del Decalogo tenutosi nel 2018, ha spiegato che il settimo comandamento, che recita “Non rubare”, non riguarda solo il furto materiale, ma anche l’ingiustizia sociale e l’accumulo illecito di ricchezze a scapito dei più deboli. La ricchezza, secondo il catechismo, non è di per sé un male, ma diventa peccato quando non viene condivisa con chi vive nella povertà.
Da questi spunti di riflessione, ritornando alla sentenza in questione, sarebbe interessante lanciare una provocazione filosofica. La nostra democrazia, non avendo garantito, attraverso le sue politiche sociali ed economiche, le condizioni necessarie per evitare che questa donna arrivasse a compiere un atto disperato per sopravvivere, non potrebbe essere chiamata a rispondere di istigazione a delinquere? Una cosa è certa: una democrazia può definirsi completa solo quando offre le reali condizioni affinché le persone non siano costrette a scegliere tra la sopravvivenza e il rispetto della legge.☺