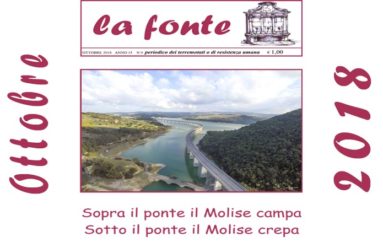Filiere colte
La filiera designa l’insieme degli elementi e dei passaggi che agiscono lungo tutto l’itinerario di un prodotto, dallo stadio iniziale della produzione fino a quello della sua utilizzazione. Il termine si applica in primo luogo, ma non solo, alle produzioni agroalimentari, cioè a beni generati dall’agricoltura e destinati all’alimentazione umana. Dalla terra alla tavola, in sintesi.
Solitamente si parla di filiere lunghe e di filiere corte, in uno schema binario nel quale quelle lunghe sono articolate in una pluralità di passaggi intermedi e di operazioni, soggetti, luoghi che progressivamente si allontanano dalla zona di origine; mentre le filiere sono corte quando si passa più rapidamente e in modo ravvicinato dalla produzione al consumo, con minori passaggi intermedi e con distanze brevi in termini geografici e sociali (dal produttore al consumatore). Nel concetto di filiera c’è quindi anche una dimensione territoriale, legata alle distanze percorse dalle materie prime nei processi di trasformazione, conservazione e distribuzione: le filiere lunghe – nazionali o internazionali – tendono alla scala globale e alla delocalizzazione, mentre quelle corte privilegiano la dimensione locale o al massimo regionale, accorciando la catena intermediaria. Quelle lunghe sono energivore e ambientalmente poco sostenibili, quelle corte significano risparmio e salute. Da simili considerazioni discende la necessità di ripensare le logiche dello scambio e della circolazione dei prodotti.
Lo scambio è sempre esistito, il mercato no. Così come noi lo intendiamo, cioè come forza ordinatrice della circolazione delle merci e della società, è figlio del capitalismo; una mano invisibile che da Adam Smith e dalla rivoluzione industriale in poi ha regolato i rapporti tra produzione e consumo, oltrepassando i confini dell’economia per condizionare anche la sfera sociale, cioè quella dei diritti e della vita delle persone. Soprattutto agendo in maniera selettiva tra individui e territori, introducendo una logica competitiva che ha prodotto una struttura gerarchica della società. Il mercato globale ha spinto verso l’omologazione dei consumi e la concentrazione della popolazione, marginalizzando i territori più deboli. Nella manifattura come nell’agricoltura, le filiere tra produzione e consumo si sono allungate, con un bilancio ambientale sempre più negativo, un maggiore impatto sulla natura, una perdita dell’identità dei luoghi e della peculiarità dei prodotti. Si pensi al cibo, ma anche all’ artigianato. Per reagire a questa situazione di progressiva spersonalizzazione è necessario tornare a consumare secondo logiche di prossimità, quando possibile. Mangiare local, vestire local…, accorciare insomma le filiere dello scambio, ritrovando un rapporto diretto tra produttore e consumatore.
Il dibattito sulle filiere corte e lunghe si è molto sviluppato negli ultimi anni in ambito economico, sociale e politico, facendo emergere la necessità di una riconsiderazione del rapporto tra agricoltura e mercato, tra sistemi produttivi e tipologie dello scambio, tra produzione e consumo di cibo in particolare. Fatte le dovute distinzioni tra filiere corte e lunghe, oggi appare sempre più necessario spostare questo dibattito dal piano economico a quello ambientale e a quello culturale, introducendo una terza opzione: quella della filiera colta come integrazione del concetto di filiera corta. Sfruttando l’assonanza lessicale tra coltura e cultura, ciò significa recuperare la consapevolezza dell’origine di ciò che mangiamo, riacquisire coscienza che nei nostri piatti confluiscono il lavoro (dell’uomo e della natura), le tecniche di produzione, di trasformazione e di distribuzione dei prodotti, il clima e i valori simbolici.
Si potrebbe partire dalla domanda “Che paesaggio hai nel piatto?” per riattivare la nostra capacità di immaginare un campo di grano dietro al pane o alla pasta, un oliveto corrispondente all’olio che si versa come condimento, un pascolo dietro al latte o al formaggio, un meleto mentre si sbuccia una mela… e così via, passando dal linguaggio del cibo a quello dell’ agricoltura e dell’allevamento. Non sarebbe solo un’operazione culturale, ma anche etica e civile nel senso di un riconoscimento dell’importanza del cibo come strumento per riconnettere la città alla campagna e per ridare voce al mondo rurale. In questo modo i prodotti alimentari, l’ enogastronomia, diventeranno anche una fondamentale leva di sviluppo dei territori. Affinché ciò avvenga è necessario, prima di tutto, conoscere i prodotti del territorio e mettere nel piatto quelli, prioritariamente, riunire il gusto del mangiare e del bere alla bellezza del paesaggio, che come il cibo è prodotto dall’ agricoltura in quel processo virtuoso di cooperazione tra natura e cultura (coltura).
Tra filiere lunghe e filiere corte, dunque, sarebbero in definitiva da preferire le filiere colte, per andare oltre il mercato, sapere davvero cosa si mangia e vedere nell’ agricoltura e nella cooperazione tra uomo e natura il principale elemento di riproduzione della vita sulla terra.☺