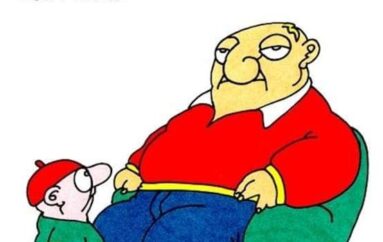Le lingue della bibbia
Scriveva S. Teresa di Gesù Bambino: “Se fossi stata prete avrei studiato a fondo l’ebraico e il greco per conoscere il pensiero di Dio”. Ha potuto dire ciò perché solo dal periodo dell’Umanesimo si sono recuperate le due lingue sacre originali della bibbia, mentre per tanti secoli in occidente si faceva fatica a trovare chi leggesse greco ed ebraico e, nonostante la presenza massiccia di ebrei in Europa, non si faceva molto per approfondire la cultura e la lingua in cui è stato scritto l’Antico Testamento. Ancora più sorprendente è il fatto che il cristianesimo sin dalle origini ha quasi totalmente ignorato la bibbia ebraica, avendo accesso invece alla sua traduzione greca che, nata all’interno dell’ebraismo, fu presto adottata come bibbia dai cristiani i quali dicevano che fosse ispirata da Dio. Le prime polemiche tra giudei e cristiani erano fondate sul testo greco, e la maggior parte degli ebrei parlava greco; solo ad un certo punto, dopo alcuni tentativi di ritradurre la bibbia in greco dall’ebraico, il greco fu sostanzialmente abbandonato e si impose il testo ebraico che tutti conosciamo, chiamato testo masoretico. In realtà l’ebraico non era parlato più e anche in Palestina gli ebrei (compreso Gesù e i suoi discepoli) parlavano aramaico: l’ ebraico era una lingua morta e fu lingua parlata prima dell’esilio; lo è tornata ad essere solo nel XX secolo, come lingua ufficiale dello Stato d’Israele.
È significativo che la lingua sacra per eccellenza della bibbia (il greco lo è soprattutto per il Nuovo Testamento) sia stata misconosciuta dai cristiani fin dagli inizi; l’eccezione fu Origene che studiò a fondo l’ebraico ed editò l’Antico Testamento in più colonne (gli esapla), un’opera purtroppo perduta nella quasi totalità. Dopo di lui fu Girolamo a simpatizzare per la veritas hebraica e a tradurre la bibbia in latino direttamente dall’ebraico che aveva studiato durante il suo ritiro a Betlemme. Un’altra sorpresa è il fatto che anche gli ebrei hanno dovuto reimparare l’ebraico in quanto, da dopo l’esilio, hanno sempre parlato le lingue dei diversi popoli con cui erano a contatto o hanno creato lingue che mischiavano parole ebraiche o aramaiche con le lingue locali (come l’Yiddish); persino la pronuncia dell’ebraico è cambiata nel tempo: se si confronta la traslitterazione dell’ebraico fatta da Origene con la pronuncia attuale dell’ebraico, ci sono molte differenze e l’ebraico parlato oggi deriva dall’inflessione acquisita nel Medioevo soprattutto nelle aree di dominazione araba. Per fortuna il testo scritto è rimasto stabile nel tempo per cui non c’è molta differenza tra i testi biblici di duemila anni fa trovati a Qumran e quelli di mille anni fa, tramandati in alcuni codici manoscritti. Tra queste due epoche non si conservano molti testi scritti in ebraico per l’uso tipico degli ebrei di non conservare testi troppo usurati ma anche di non abbandonarli per il timore che fossero profanati da mani impure: erano conservati invece in depositi nei pressi delle sinagoghe, chiamati ghenizàh (famosa è quella del Cairo da cui sono emersi tanti frammenti in ebraico).
I due più importanti e antichi codici della bibbia ebraica sono il Codice di Aleppo che risale al 930 d. C. e il Codice di Leningrado, copiato nel 1008 d. C. Il primo di essi era stato addirittura consultato dal più importante studioso ebreo medievale, Mosè Maimonide, ma oggi è purtroppo mutilo a causa di un incendio della sinagoga di Aleppo, dove era custodito, nel 1947. Non avendo mai permesso di fare una riproduzione fotografica, i custodi del codice hanno fatto perdere un grande patrimonio all’intera umanità. Per fortuna il Codice di Leningrado (oggi di San Pietroburgo) è un codice completo ed è diventato il manoscritto base per l’edizione odierna più usata negli studi biblici: la biblia hebraica stuttgartensia. In ambito cristiano, dopo Girolamo, tranne qualche lodevole eccezione come Andrea di S. Vittore nella Parigi del XII secolo e Nicola di Lyra (secondo alcuni ebreo convertito) nel XIV secolo, nessun cristiano leggeva la bibbia in ebraico; anzi, spesso si accusavano i maestri ebrei di aver corrotto il testo biblico per cui non ci si poteva fidare dei loro manoscritti (una falsità dimostrata definitivamente grazie alle scoperte archeologiche degli ultimi secoli).
Solo con l’invenzione della stampa si cominciò a prendere più confidenza con l’ebraico, non solo in ambito protestante dove ci fu una vera esplosione degli studi, a cominciare dall’università di Wittemberg dove Lutero volle istituire la cattedra di ebraico, ma anche in ambito cattolico, dove con la Poliglotta Complutense, voluta dal cardinale spagnolo De Cisneros, la Parola di Dio fu presentata per la prima volta nelle due lingue sacre originali e nella traduzione latina della Vulgata. Da allora di acqua sotto i ponti ne è passata eppure l’ebraico, nell’ambito degli studi teologici, è ancora considerato una curiosità esotica: manca il desiderio espresso da S. Teresa, convinta che con l’ebraico abbiamo accesso alla mente stessa di Dio.☺