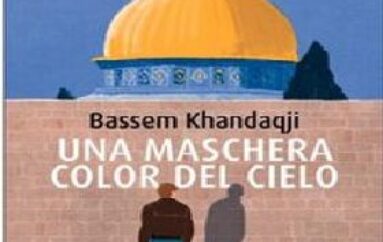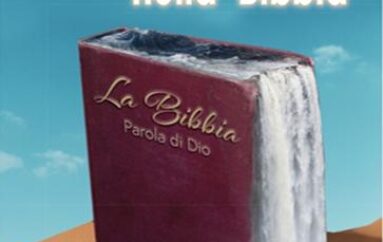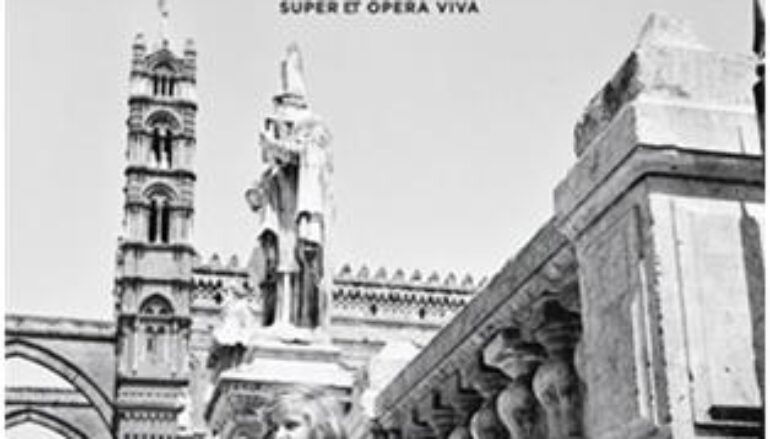
libri: “SE AMORE GUARDA” di TOMASO MONTANARI
“Ogni volta che entriamo in contatto con il patrimonio culturale, riattribuiamo significato alle cose, ai luoghi fino a sentirli parte della nostra esistenza, quasi estensioni del nostro corpo”. E di questo legame profondo, privilegio per noi esseri umani – soprattutto in Italia – ci parla, con la sua prosa chiara e puntuale, l’ultimo saggio di Tomaso Montanari, Se amore guarda.
Prendendo le mosse dalla ferma convinzione che il “discorso sul patrimonio è un discorso sulla custodia, non sul possesso”, lo storico dell’arte si richiama ad una tesi espressa dallo scrittore Carlo Levi nel suo commento agli scatti del fotografo ungherese Jànos Reismann (Un volto che ci somiglia. Ritratto dell’Italia, Einaudi 1960). Sostiene infatti Levi che “nessun paese del mondo forse è stato così guardato […] come l’Italia. […] Se gli occhi guardano con amore, se amore guarda, essi vedono”.
È quindi con una ritrovata, o meglio conquistata, educazione sentimentale che possiamo guardarci intorno, apprezzare le opere d’arte come anche i luoghi, i paesaggi, le atmosfere che nel loro insieme costituiscono il nostro prezioso patrimonio. “Un luogo che è il tempo, il tempo che è un luogo: il patrimonio come cerniera fra altri tempi e il nostro presente”, per seguire la lezione di Carlo Levi. Non soltanto ruderi o vecchie rovine ma testimonianze di quanti ci hanno preceduto ed il cui contributo al genere umano non può essere negato o cancellato: “da un punto di vista laico, è il patrimonio culturale l’unico possibile luogo materiale di una comunione tra i vivi e i morti”.
E tale insieme di testimonianze e di opere presenta, in maniera incontrovertibile, un carattere plurale ed estensivo che occhi miopi tendono a non vedere: identità porose le definisce il nostro autore. Infatti “siamo figli di civiltà diverse che si incontrano, e si intrecciano, in una comunanza frammentaria, che ci permette di andare oltre le contrapposizioni della storia”.
Senza dimenticare, infine, che tanta parte di ciò che oggi continuiamo ad ammirare, che richiama nel nostro Paese milioni di turisti, è stato possibile grazie alla fatica – mai considerata, anzi negletta e taciuta – di tanti operai, minatori, manovali senza i quali non ci sarebbero state le indimenticabili opere del nostro patrimonio. Montanari riferisce l’esempio di un quadro del pittore veronese Jacopo Ligozzi nella chiesa di Sant’Andrea in Percussina, mirabile per il colore intensissimo del cielo, un blu ottenuto da pietre di lapislazzuli: “seduto in quella chiesina tra gli ulivi della campagna toscana […] mi chiedo che faccia avessero, a quale età arrivassero, in quali condizioni vivessero, cosa chiedessero nelle loro preghiere […] i minatori che estrassero quel lapislazzulo dalle miniere delle montagne del Badakhshan, nell’attuale Afghanistan nord-orientale”.
Il saggio è dedicato “alla luminosa memoria di don Lorenzo Milani, inarrivabile maestro di amore”. (D. C.)