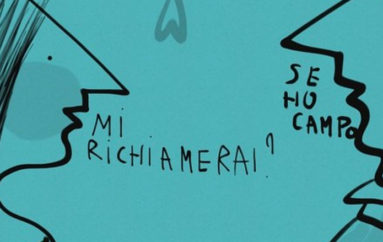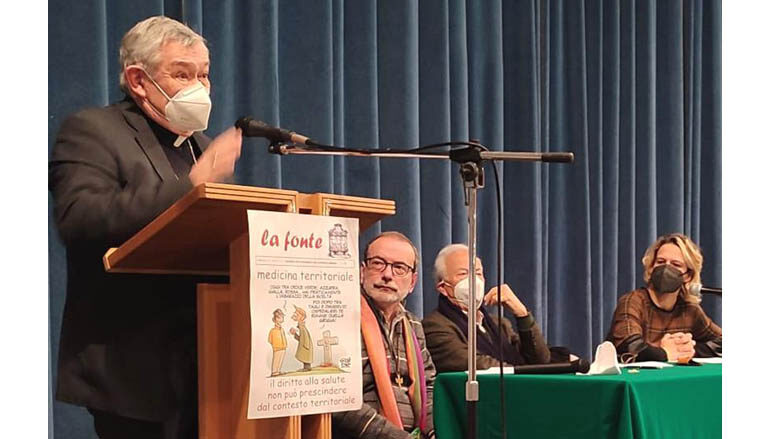
La medicina sul territorio
La riorganizzazione della Medicina del Territorio è la sfida decisiva della sanità italiana. Decisiva e non rinviabile sia per lo Stato, che non può più permettersi spese e dispersioni inutili di fondi e ancor di più per le persone, che non trovano risposte adeguate ai loro problemi di salute.
La pandemia ha messo in evidenza che la sanità pubblica deve riacquistare un ruolo centrale e decisivo nella scelte delle azioni (strutture, operatori, organizzazione) che rispondano realmente ai bisogni delle persone. Negli ultimi decenni le metodologie di assistenza socio-sanitaria sono state conseguenza di cambiamenti culturali, talvolta positivi: “prendersi cura invece che curare”, talvolta negativi: “utente e non più malato o paziente” .
L’adeguamento delle strutture e dell’organizzazione della sanità pubblica alle nuove esigenze della popolazione (invec- chiamento, aumento delle malattie croniche degenerative ecc.) è avvento in modo non uniforme, attuato a macchia di leopardo sull’ intero territorio nazionale e in modo molto approssimato sul nostro territorio. Uno dei primi ostacoli al buon funzionamento della Sanità è quello della burocrazia nell’accesso alle prestazioni. Basta paragonare la prenotazione per un albergo o un posto in treno, per i quali basta un messaggio sul telefonino, con la prenotazione di un esame radiografico o di laboratorio, per la quale oltre alle ore di fila agli sportelli c’è bisogno di 2/3 fogli di carta per l’autorizzazione.
Il concetto di “salute” così come oggi viene ridefinito dalla Organizzazione Mondiale della Sanità: “capacità di adattamento e di autogestirsi di fronte alle sfide sociali, fisiche ed emotive”, esige nuove metodologie e pone nuovi risvolti socio-economici. Ne scaturiscono nuovi e diversi approcci nell’assistenza: il benessere fisico e mentale, oltre che sociale, difficilmente è compatibile con l’invecchiamento della popolazione: pensiamo alle malattie croniche degenerative, quelle osteoarticolari o neurologiche come Parkinson e Alzheimer. Di conseguenza, la sanità pubblica deve provvedere a potenziare le capacità di autogestione e adattamento sociale, fisico e psichico.
I nuovi indirizzi della medicina ospedaliera, la cura breve, il Day Hospital, la preospedalizzazione rispondono ai princìpi del risparmio di risorse e a quelli clinico-preventivi delle infezioni, che si contraggono: meno stai in ospedale, minori sono le possibilità di contrarre un’infezione da batteri resistenti! Sulla scorta di queste nuovi concetti da oltre un decennio la medicina del territorio ha cominciato a muovere i primi passi (poliambulatori territoriali, RSA, studi medici associati), ma purtroppo non tutti e non sempre rispondenti alle crescenti necessità della popolazione, e soprattutto non adeguati alle esigenze della crescente deospedalizzazione ormai iniziata e in avanzato stato di realizzazione.
Nel nostro territorio si è attuata la deospedalizzazione, ma senza aver completato la preventiva o almeno sincrona attivazione delle strutture e attività territoriali. La pandemia ha evidenziato e acuito queste pericolose discrepanze: progressiva destrutturazione degli ospedali (o forse sarebbe meglio dire, per il Basso Molise, distruzione degli ospedali) e territorio che si affanna e stenta a raggiungere la sua giusta funzione, nonostante le strutture distrettuali di Termoli-Larino stiano salvando il territorio, assicurando prestazioni accettabili, grazie anche all’impegno dei singoli.
In questo scenario (di cui non vogliamo approfondire le colpe) il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza potrebbe essere l’àncora di salvezza o, come si suole dire, l’ultima spiaggia per questo territorio. È una occasione che i Basso Molisani non possono perdere.
L’obiettivo per il Basso Molise, in ossequio al PNRR, deve essere il ripotenziamento dell’Ospedale e, di pari passo, il potenziamento della rete territoriale, in tutte le sue componenti, entro il giugno del 2026, tramite l’AGENAS servizi sanitari regionali, i cui passi salienti sono:
– Casa come primo luogo di cura. Erogazione delle cure domiciliari con indispensabile ricorso alle nuove tecnologie di telemedicina, domotica e digitalizzazione. L’ implementazione della telemedicina per i pazienti cronici (investimenti 1.1 e 1.2 della componente 2 della Missione 5) ridurrebbe i ricoveri inappropriati, migliorando l’attività ospedaliera e rendendola disponibile per i pazienti con patologie complesse e non trattabili sul territorio.
– Realizzazione di sistema informativo dell’ASL per la rilevazione dei dati clinici domiciliari in tempo reale, per la loro sorveglianza e la risposta terapeutica conseguente (telemonitoraggio, teleassistenza, teleconsulto, telerefertazione).
– Case della salute o comunità. Struttura polivalente in grado di erogare nello stesso spazio fisico prestazioni socio-sanitarie. In essa sono allocati gli studi dei medici di Medicina Generale (MMG ), i Medici di Continuità Assistenziale (MCA e di emergenza Territoriale (MET), oltre agli ambulatori di Specialistica ambulatoriale; vi deve operare il personale delle professioni sanitarie anche dell’area riabilitativa e preventiva, con attivazione di ambulatorio infermieristico e per le piccole urgenze. In essa gli infermieri, pur con la loro autonomia professionale, operano in collaborazione con i MMG, con l’UVM , l’ADI e il Centro diurno.
– Attivazione della Centrale Operativa Territoriale (C.O.T.) per il Basso Molise (602 in tutta Italia: una per ogni distretto), con funzione di coordinamento dei servizi domiciliari con gli altri servizi territoriali, con l’ospedale e la rete di Emergenza Urgenza.
– Rafforzamento dell’assistenza intermedia e delle sue strutture, ovverosia attivazione o potenziamento di Ospedale di Comunità (da 20 a 40 posti letto) e delle RSA (Residenza Sanitaria Residenziale). L’Ospedale di Comunità deve essere attivato per ricoveri brevi per pazienti che necessitano di interventi a media o bassa intensità clinica. (Investimenti 1.3- Componente 2 – Missione 6), e svolgere funzione intermedia tra domicilio e ricovero ospedaliero.
Questi sono gli interventi strutturali e organizzativi che devono essere realizzati. E la loro realizzazione deve essere completa e coordinata, pena il fallimento di tutta la rete assistenziale ospedaliera e territoriale.
In questo scenario gli Organi istituzionali del territorio, i Comuni, i Sindaci, i Consigli comunali, il Vescovo, ma anche le Associazioni di volontariato, i comuni Cittadini, tutti coloro che hanno un minimo senso civico, cosa sono obbligati a fare? Tutti noi siamo chiamati a esercitare completa e attenta sorveglianza che tutto ciò si realizzi. E questa sorveglianza non va attuata a consuntivo, ovverosia nel 2026, ma da domani per sorvegliare che i passaggi legislativi siano fatti e fatti nella direzione giusta.
Non possiamo più delegare altri per la tutela della salute, nostra e delle nuove generazioni!☺