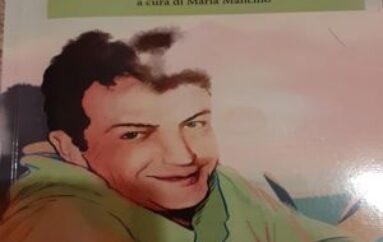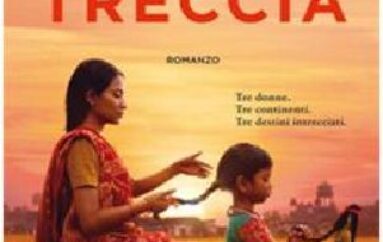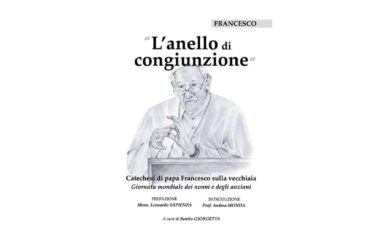libri: “I NON RAPPRESENTATI” di Valentina Pazè
libri: “I NON RAPPRESENTATI” di Valentina Pazè
“La maggior parte dei cittadini non ci fa nessun favore ad andare a votare. Chiedere a tutti di votare è come chiedere a tutti di buttare immondizia in giro”: non sorprendono queste affermazioni – oggettivamente deplorevoli – estrapolate dal pensiero contemporaneo di alcuni filosofi della politica come lo statunitense Jason Brennan, autore anni fa di un saggio dal titolo eloquente, Contro la democrazia.
Valentina Pazé, docente di Filosofia politica presso l’Università di Torino, si interessa di questa tematica nel suo saggio I non rappresentati – Esclusi, arrabbiati, disillusi, edizioni GruppoAbele, partendo dal presupposto che al giorno d’oggi “tra rappresentanza e democrazia è in corso un divorzio”.
È innegabile che le democrazie odierne stiano attraversando un periodo di crisi e che i governi in carica non siano rappresentativi dell’intera società dei singoli Stati. Fermo restando che una democrazia diretta – quella che discenderebbe automaticamente da un mandato popolare – si tradurrebbe in plebiscito e altre conseguenti forme di autoritarismo, la professoressa Pazé analizza i problemi che la forma di democrazia rappresentativa incontra, a partire dai diversi tipi di rappresentanza, il riconoscimento dei diritti politici dei cittadini e la negazione del diritto di voto ad alcuni di loro.
Lo sguardo dell’autrice non si limita soltanto al nostro Paese, ma prende in esame le democrazie occidentali – Europa e Stati Uniti – con qualche riferimento agli Stati latinoamericani. Negli U.S.A., ad esempio, la partecipazione al voto è facilmente ostacolata in quanto esso è un diritto che richiede l’iscrizione alle liste elettorali dietro pagamento di una somma di denaro che gli indigenti non possono permettersi.
Alle ultime elezioni in Italia la partecipazione al voto è risultata molto bassa: “a tenere i potenziali elettori lontani dai seggi non sono solo l’ignoranza, la stanchezza, il disinteresse, ma in casi sempre più numerosi la scelta consapevole, e spesso sofferta, di ‘mandare un segnale’ alla classe politica, che in genere fa fatica a recepirlo”.
L’allontanamento di buona parte della popolazione dalla politica nazionale può essere inteso quale forma di contestazione non sempre intercettata da quelli che una volta erano i pilastri della democrazia, vale a dire i partiti politici.
Prendendo ad esempio il romanzo capolavoro dello scrittore americano John Steinbeck, Furore, Valentina Pazé osserva: “dietro di noi non c’è l’età dell’oro, ma un tempo in cui la violenza e la prevaricazione nei confronti dei deboli non trovavano neppure un fragile argine in uno Stato in grado di far rispettare la legge e in sindacati e partiti schierati dalla parte dei subalterni. E tuttavia, gettando uno sguardo d’insieme al secolo che abbiamo alle spalle, l’impressione è che dare uno sbocco costruttivo al ‘furore’ sia, oggi, più difficile”. (D.C.)