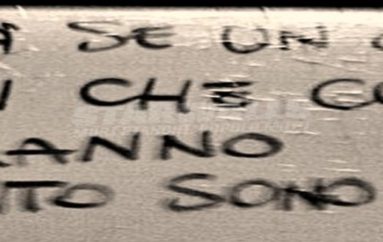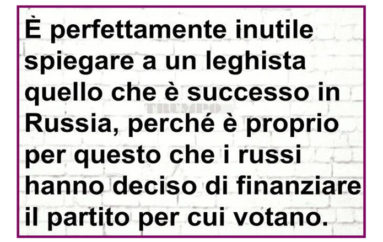La parola negata
“Tu prova ad avere un mondo nel cuore, e non riesci ad esprimerlo con le parole…”
Il genio inarrivabile di De Andrè tradusse in musica, nel lontano 1971, le storie di alcuni personaggi dell’Antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters. Disco e libro che furono amati compagni di strada per tantissimi adolescenti della mia generazione.
E “Il Matto” è una delle canzoni che immediatamente fecero presa sul nostro immaginario, perché c’era tutto, dentro quelle note: la diversità, la solitudine, la fascinazione della lingua che rende uguali e ci fa accettare socialmente, la tragedia del manicomio dove restituire la vita.
Di parole negate e di esclusione sociale, appunto, abbiamo chiacchierato a Termoli il 12 novembre con Anna Paolella, pedagogista dell’Università del Molise, durante uno degli eventi collegati alla mostra foto-documentaria “I Fiori del Male, Donne in manicomio in epoca fascista”, che Termoli ha ospitato per dieci giorni grazie all’associazione “Mai Più Sole-Non Una di Meno”.
Come il matto di De André, le donne della mostra non furono in grado di dare voce a ciò che si agitava dentro di loro; e furono inghiottite dalla “fabbrica della follia” che il regime aveva costruito per eliminare ogni diversità. E la struggente lotta del giovane Frank Drummer (questo il nome che Lee Masters diede al suo pazzo) per imparare la Treccani a memoria ci riporta intero il desiderio di parole che traspare dalle lettere e dalle cartelle cliniche delle internate del ventennio, donne, bambine e adolescenti accomunate da miseria, fame, ignoranza e desiderio di libertà.
Ciò che fu chiamato pazzia era quasi sempre conseguenza dell’incapacità di difendersi con le parole dagli attacchi di un sistema che non ammetteva diversità dallo stereotipo femminile di regime. Perché come don Lorenzo Milani intuì lucidamente nel 1957, finché si conosceranno solo 50 parole e ci si troverà a confrontarsi con chi ne conosce 2000, si sarà fatalmente perdenti. Solo la lingua rende uguali, e di conseguenza liberi.
E riflettendo sugli spunti scaturiti dalla gradevolissima esposizione di Anna Paolella e dalla vivace discussione che è seguita, mi ha colpita la straordinaria inversione di senso che Shakespeare opera nelle sue tragedie: lì il Fool (il Matto, letteralmente lo sciocco) è l’unico cui viene concessa la parola, la sola persona che possa leggere la realtà come essa è e rivelarne l’essenza. In una parola, l’unico che possa dire la verità al re, al potere, senza esserne schiacciato. Mentre i matti dei manicomi sono chiusi proprio perché non si parli più di loro.
Diventa evidente così che la pazzia ha in sé i germi della rivoluzione, che la diversità deve essere esorcizzata, o rinchiudendola perché imperfetta, come le donne da manicomio, o costringendola al ruolo del buffone di cui ridere. E solo attraverso la parola si può cercare di difendersi da etichette e ruoli che il mondo ci cuce addosso, e si può reagire a stereotipi che ci ingabbiano. Ma se povertà e ignoranza negano la parola, non c’è possibilità di riscatto.
E balza agli occhi la differenza tra la lingua elementare, assertiva e povera delle dittature, che serve a dare certezze e ad eliminare obiezioni e contraddittorio, e le parole liquide e problematiche delle democrazie, che invitano al confronto, alla discussione, alla bellezza del dubbio. Persino la sintassi tradisce questa dicotomia: semplificata, costruita con frasi brevi e coordinate quella del dominio; complessa, ricca di incisi e subordinate quella del pluralismo.
Sono le parole a dare autonomia, libertà, capacità di difendersi da chi vuole uniformare il nostro modo di essere e di vivere; solo attraverso la parola siamo messi in grado di leggere la realtà, e di accorgerci quando essa viene distorta. Ma sono le parole stesse a modificare la realtà, se usate in modo manipolatorio e private del loro senso distintivo, come purtroppo sta accadendo intorno a noi.
E se in passato sono stati per lo più miseria ed analfabetismo a togliere la parola, oggi stiamo rischiando seriamente di perderla perché alterata, forzata a indicare qualcos’ altro da sé, ripetuta ossessivamente fino a diventare un moloch, espropriata di senso e umanità: migrante, sicurezza, flessibilità, progresso, riqualificazione, razionalizzazione non sono forse diventate parole in-significanti, o meglio non-significanti? Ma efficacissime per una fabbrica di consenso aprioristico.
Quindi la parola può essere negata perché non riesci a farla uscire dal cuore, o perché non riesci più a ritrovare in essa quel patrimonio comune di senso intorno al quale si costruisce una lingua, e i valori condivisi di una comunità. E siamo sconfitti in tutti e due i casi, sia se come le donne del manicomio di Teramo non troviamo le parole, sia se lasciamo che i significati delle parole divengano incerti, rendendo insicuro anche il senso delle nostre azioni.
È necessario quindi ritrovare insieme un significato al nostro operare: riprendendoci le parole negate. O perse.☺