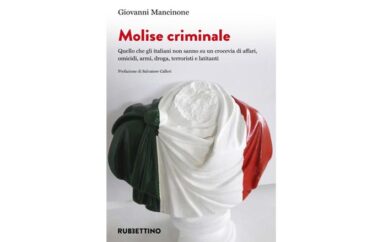Fuggire l’onda melliflua
Sarà stata la caduta del muro di Belino che, azzerato il conflitto ideologico internazionale ed interrelazionale, ha instaurato urbi et orbi un clima di generale tolleranza evolutasi poi in facile sentimentalismo, o saranno stati i telefonini, rei per definizione, che nello spazio limitato del display ci hanno indotto ad esprimere sentimenti i più nobili in forma di sigle per amore di economia dirette a gruppi di amici indistinti anziché ad personam, fatto è che sempre più spesso e in maniera sempre meno opportuna sento chiamarmi “cara”, “carissima”, “amore”, “tesoro”, “stellina” da persone – donne in particolare – con le quali ho rapporti di blanda conoscenza e rara frequentazione. Puntualmente rimango intirizzita, rigida come uno stoccafisso; mi proverei a ricambiare, così, per adeguarmi, ma proprio non mi riesce, al limite sorrido; infine, mi pervade una sensazione di disagio misto a senso di colpa per non essere riuscita a corrispondere.
Non sono patologicamente introversa o clinicamente anaffettiva; la realtà è che, quando non sento, non dico: tutto lì.
Le parole sono importanti, diceva Nanni Moretti in Palombella Rossa. E importanti sono quelli che le parole le usano bene, per dirsi o per dire.
Scudo e corazza, passaporto e arma di seduzione, sasso e nudità, a seconda, le parole sono l’alternativa all’ incomprensione, alle botte, all’umiliazione.
Purché siano vere e nascano per diretta filiazione dalla realtà che indicano, non importa se questa sia effettiva o immaginata, ché altrimenti tanta parte della poesia sarebbe da considerarsi ingannevole, né importa che le parole siano adoperate per rovesciare consapevolmente la realtà che indicano, altrimenti non esisterebbero ironia e comicità. L’inganno della parola, la parola non vera, è la parola abusata, che non ha legame con quel che predica, né per affinità né per antifrasi. La parola fatta eremita da questo legame di senso disorienta e stordisce, è orpello retorico, vana come l’illusione ottica di un proscenio barocco, ridondante come una collana di zirconi al collo di una donna che già indossi un giro di diamanti.
Sono cresciuta in una comunissima famiglia molisana nella quale i vincoli di parentela vengono robustamente onorati e ho avuto la fortuna di amicizie solide e fidate da ché ero adolescente: mai che mi si sia chiamata “amore” o “tesoro” o “stellina”; “cara”, poi, era rigorosamente relegato agli incipit delle lettere – quando ancora si usava spedirle -, allorché la distanza dei corpi esigeva una presa in carico preliminare in termini di affetto, per accendere calore azzerando i chilometri.
Se frugo nei ricordi, da parte di genitori e zii e nonni non trovo rivolto a me nemmeno un diminutivo o un vezzeggiativo, perché Luciana era – ed – è – estesamente pronunciato con una punta di orgoglio integralista fin negli scontri più aperti; “Lucy” sì, o anche “Lucianina” me lo hanno detto e me lo dicono gli amici, complice una strizzata d’occhio, quasi una gag fumettistica, nei momenti di maggiore effusione: non plus ultra. Ma io così sto bene, perché gli affetti hanno il loro peso specifico e il loro specifico nome.
È di qualche giorno fa la notizia che 600 accademici italiani hanno rivolto una lettera-appello al governo, denunciandovi le diffuse carenze linguistiche degli studenti universitari italiani e sollecitando il governo perché realizzi interventi concreti sulla scuola e nella scuola in direzione del recupero della padronanza della patria lingua da parte di giovani e giovanissimi.
La questione delle responsabilità della scuola nel livello di preparazione ovvero di impreparazione dei giovani è annosa e complessa; mi viene da pensare, però, che, se è vero che la scuola ha in materia di formazione linguistica il ruolo di attrice primaria, è pur vero che scelte lessicali, grammatica, sintassi, uso linguistico in generale sono anche specchio dei gusti e dei desideri, delle manie e dei timori, della visione del mondo insomma che la società nel suo intero esprime.
Credo che sulla strada virtuosa della riconquista di dignità all’Italiano da parte degli studenti e bensì dei non studenti stia proprio la restituzione di senso appropriato alle parole, in particolare a quelle che indicano affetti e sentimenti e che meglio hanno a che fare con la relazione umana, per la quale il nitore è aspetto essenziale.
Davanti al cerchio magico delle parole logore e vuote dovremmo allora essere più coraggiosi, tappare le orecchie, gridare “io non ci sto più e i pazzi siete voi”, come lo sposo dell’Alice di De Gregori; verremmo tacciati di follia o sospettati di indulgere al vino, ma ne varrebbe la pena, per fuggire l’onda melliflua del “cara” “tesoro” “amore” o, sotto altra specie, l’inane caos del “quant’altro”.
A presto.